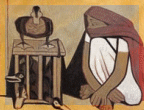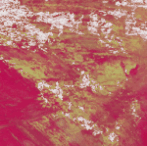Daniele Ponchiroli
La viltà che mi prende ogni volta che vengo a sapere che un amico è incappato nella malattia che non perdona agì puntuale anche nel caso di Daniele Ponchiroli (naturalmente, mi dissi a più riprese che avrei dovuto, ecc. ecc.; naturalmente, mi risposi, senz’indugio, che avevo un numero spaventoso d’impegni, ecc. ecc.). Ora lo guardo mentre riempie la pipa volto di tre quarti, in uno di quei suoi giacconi invernali a casacca, grazie a una foto di Giulio Bollati, fotografo dilettante di grande garbo: ma il guardarlo lì, su uno scaffale del mio studio, non attenua il rimorso.
Nato a Viadana in quel di Mantova nel 1924, Ponchiroli è morto a Viadana nel 1979. È stato il caporedattore della nostra casa editrice. C’era entrato su invito di Bollati, che era stato suo compagno di studi alla Normale di Pisa e che, prima di lui, nel ’54, aveva ricoperto la stessa carica. Detto così, è come non dir niente. Allora voglio aggiungere – tanto per tentare di spiegarmi meglio – che è stato, con Bollati e Calvino, uno dei tre uomini-chiave della casa editrice. Se uno dei tre non ci fosse stato (mi riferisco al periodo coperto da questo taccuino), la casa editrice non sarebbe stata: uso, con piena consapevolezza, la forma intransitiva.
Ponchiroli aveva come compito di coordinare la redazione e quella parte di redazione “in seconda”, che era l’ufficio correttori. Allora l’Einaudi ne contava sino a una dozzina; un lusso, certo non uno spreco: era assai raro che un nostro libro contenesse un errore tipografico. Alla guida dei correttori c’era un uomo dolce e buono, Nino Colombo, anche lui scomparso prematuramente, per uno stupido incidente stradale. Colombo si esemplava – fatte salve le proporzioni – su Ponchiroli a perfetta immagine e somiglianza. Aveva assorbito il gene di Ponchiroli e lo aveva inoculato nella sua magnifica squadra di ragazzi e ragazze. E questo era il gene della precisione.
Non ho mai conosciuto una persona altrettanto precisa che Daniele Ponchiroli. Questa precisione cominciava dalla calligrafia: piccola, regolare, uniforme, di una sorprendente chiarezza. Qualunque nota, promemoria, appunto di Ponchiroli – e nel corso della giornata ne vergava di continuo – era di lettura immediata e non necessitava di alcuna battitura a macchina. Daniele ne teneva un esemplare, ne faceva una o più copie a mano per gli interessati, a cui le portava lui stesso, senza servirsi di fattorini o segretarie. A conservarli uno a uno si aveva a fine giornata il “giornale dei lavori” dell’azienda. Ma era pleonastico, perché lui, ogni sera, prima di staccare, metteva a punto un diario della giornata stessa.
Sto delineando il ritratto di un perfetto funzionario; ma Daniele, formatosi alla stessa scuola di Bollati e con gli stessi maestri, era un eccellente studioso. Una della due antologie di Libri del Cinquecento che ancora reggono è sua (l’altra è quella di Luigi Baldacci, anche lui scomparso). Ma il suo capolavoro di colto e intelligente annotatore è l’edizione 1964 del Canzoniere di Petrarca, per cui è noto tra tutti gli italianisti, anche tra quelli che non l’hanno mai incontrato. Gliel’aveva commissionata Gianfranco Contini stesso, e tra noi era rimasto memorabile lo scambio tra i due: “Come lo vuole, professore, il commento?”, aveva chiesto timidamente Ponchiroli. “Me lo faccia alla fiamma ossidrica”, aveva risposto il Maestro di Domodossola, che al parlar figurato non rinunciava mai.
Occorre ora ch’io dica che quest’uomo, di una lindura nel tratto e nelle scritture incomparabile, era profondamente inquieto e di continuo afflitto dai turbamenti più diversi, grandi e piccoli. Lo scrivo con la stessa tenerezza e partecipazione con cui tutti noi, suoi amici prima che colleghi, abbiamo vissuto al suo fianco il suo dramma quotidiano. La precisione, per cui – ripeto – rifulgeva, era il risultato di una costante messa in ordine di un suo privato disordine interiore. Anche quel giornale di bordo, quel diario a metà tra pubblico e privato (nessuno, significativamente, dopo la sua scomparsa, ha pensato mai di pubblicarlo), era una testimonianza del suo continuo impegno a riequilibrare ciò che lui, immerso nella convulsa attività di un collettivo intellettuale, avvertiva come disequilibrato.
Daniele teneva appesi a casa dei quadri che veniva dipingendo, e che non mostrò mai in pubblico: di gusto astratto, erano geometricamente impeccabili. Era anche illustratore per ragazzi (sue sono le tavole di due libri di Marina Jarre e Augusto Monti) e si provò, sotto pseudonimo, in un suo romanzo per l’infanzia, molto suggestivo. Nessuno di noi gli chiese mai perché lo facesse: ma, probabilmente, il mondo dell’infanzia (curava con molta finezza la collezione Ragazzi, che vantava titoli gloriosi come il Marcovaldo calviniano e la Caterina della Morante) rappresentava per lui un’oasi di quiete e di silenzio.
Ciò che tuttavia mi ha sempre colpito è che – al di fuori della nostra piccola cerchia – nessuno avvertì mai il tumulto che lo agitava. Sto parlando degli “esterni”, gli autori grandi o piccoli, giovani o vecchi che fossero. Ponchiroli rappresentava il pacifico polo d’attrazione, l’approdo sicuro per una congerie pittoresca di narratori e saggisti, che era talvolta assai distante da lui (o da ciò che lui s’imponeva d’essere). Ponchiroli avrebbe preteso che l’opera che veniva affidata alle sue cure, fosse, anche nelle sue esterne fattezze, la più composta possibile: in parole povere, vagheggiava d’avere sulla scrivania dei dattiloscritti (così allora usava) d’impeccabile fattura. E, invece, sembrava che i più disordinati tra i nostri autori si ostinassero a fargli la corte.
Pubblicammo per vari anni scritti di Danilo Dolci. Forse perché nascevano dal vivo di un’esperienza civile combattuta e combattiva, le opere dell’educatore di Partitico arrivavano sulla scrivania di Daniele in condizioni riprovevoli: ho visto con i miei occhi l’autore, già in procinto di congedarsi da Daniele (era il 1974), estrarre da un’immensa tasca dei pantaloni (Dolci era tutto grosso di suo) un ennesimo mannello di liriche (forse l’ultima sezione?) di Poema umano. Ponchiroli si tendeva nelle linee del volto sino allo spasimo, si vedeva che questo era per lui peggio di un insulto: l’idolo dell’Ordine – per cui tanto e tanto faticosamente lottava – era profanato. Poi, con uno sforzo supremo, si ricomponeva, tentava perfino un timido sorriso, e se ne usciva con una formula che aveva qualcosa di propiziatorio: “Vedrò di fare tutto il possibile…”. […]
La prima impressione che si prova, se si esamina un manoscritto corretto dalla mano d’un copista, è d’essere dinanzi a un pianoro accidentato, dove qualcuno ha tuttavia provveduto a colmare le buche o i dislivelli del terreno: ciò che alle prime armi ti si presenta come caotico, ti si rivela a un più attento esame come sapientemente riordinato. I manoscritti che uscivano dalle cure di Ponchiroli non erano indegni di un antico copista: e anche i più travagliati, quelli più fitti di interventi, sembravano antichi arazzi rimessi pazientemente sul telaio e restituiti (o quasi) al loro splendore.
Guido Davico Bonino, tratto da Guido Davico Bonino, Alfabeto Einaudi. Scrittori e libri
*
Collegato a Molina c’era Daniele Ponchiroli, redattore capo. Un uomo mite, che dava consigli a tutti, che seguiva in particolare gli autori con lui in sintonia con una straordinaria mitezza e cordialità di fondo verso la vita e verso gli altri. Nuto Rivelli, Mario Rigoni Stern, Primo Levi, sono autori che potremmo definire “ponchiroliani”. Avevano fatto la guerra, in Russia e sui monti, o venivano dai campi di concentramento: autori testimoni della storia. E anche Gianni Rodari, e Mario Lodi. Ponchiroli era uno della generazione dei “normalisti”, come Bollati, ma non esibiva la sua preparazione. La teneva per sé, salvo curare in proprio bellissime edizioni del Milione o delle Rime di Giovanni Della Casa, i classici italiani del Quattrocento, Petrarca; o annotare Salgari o Garibaldi; o tradurre Ionesco; o illustrare libri per ragazzi, suoi o di altri, con pseudonimi vari. Così, senza parere. E come caporedattore, tu sapevi che se usciva un libro e c’era stata la verifica ultima di Ponchiroli potevi star sicuro, come potevi star sicuro di Molina dal punto di vista grafico. Molina controllava con Ponchiroli la perfezione filologica del libro. Tra i due c’era un rapporto molto stretto: per questo il peso e la fatica vera dell’uscita dei libri, come il peso di reggere ogni imprevisto, erano in pratica nelle loro mani.
Ponchiroli fu uno straordinario esempio di mestiere editoriale non a tutti noto. Era proverbiale la sua diligenza, assoluta. Ma era anche di una furbizia contadina, per così dire. Faceva sempre il finto tonto. Su un libro approvato, osannato da tutti, sul quale però lui nel suo intimo dissentiva, richiesto di un parere diceva: “Eh, lo trovan tutti bello questo libro. Certo, certo”. Sì, ma tu che cosa ne dici? “Mah, io non so, ne parlan tutti bene. Ah sì, può darsi. Io, sai, non me ne intendo. Non me ne intendo. Non so niente”. E quando Ponchiroli cominciava a dire: non me ne intendo, voleva dire che il libro l’aveva letto, l’aveva trovato disgustoso, non l’avrebbe mai pubblicato.
Teneva un diario giornaliero. Tornava a casa e scriveva, in dettaglio: oggi è nato un figlio a…, pesa tre chili e mezzo, la madre sta bene. Calvino è andato a colazione con Lukács ai Francesi. Oggi c’è stata gran discussione, come al solito… In questo era un po’ pavesiano, chiacchiere poche. La politica lo preoccupava: la guerra fredda, la bomba atomica. Stava a sentire e notava anche i fatti di cronaca, per quanto lo disturbassero.
Tutti andavano da lui, e niente di più facile che Calvino abbia pensato a Ponchiroli, per certi tratti del dottor Cavedagna, quel personaggio di Se una notte d’inverno che è una sorta di “buco nero” dove vanno a finire tutte le grane e le incombenze del lavoro editoriale.
Negli ultimi anni ha avuto una malattia che lo tormentava, e come il protagonista di quel suo libro per ragazzi, Le avventure di Barzamino, che vuol sempre tornare a casa, anche Ponchiroli alla fine chiese di ritirarsi al suo paese, Viadana, sul Po vicino a Luzzara, il paese di Zavattini. Lì aveva una casa che aveva costruito o ampliato lui, dove viveva con la moglie Carla e il figlio adottivo.
Quando lui è partito si è creato un vuoto. Non un vuoto di potere, ma di tessuto connettivo, come se fosse venuto a mancare qualcosa di essenziale, come se tra un organo e l’altro non ci fossero più stati legamenti, legami, un vuoto quindi molto difficile da colmare.
Eravamo alla metà degli anni Settanta, e lui, in questi ultimi anni, da Viadana, prima che il terribile morbo avesse ragione del suo amore della vita, leggeva e schedava i dattiloscritti che gli mandavamo, o che gli spedivano direttamente gli amici, prima che a noi: Rigoni, Lodi, Munari, Rodari. Era impressionante la sua accuratezza nei giudizi.
Giulio Einaudi, tratto da “Il lavoro editoriale”, in Severino Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi
*
Cerchiamo che fin dall’infanzia i giovani di domani non siano come quelli del ’68, in rottura con tutto e con tutti, ma in realtà in rottura con se stessi, senza alcun retroterra su cui poggiare i piedi per spiccare un concreto salto in avanti. Era mancanza di cultura e di fantasia, e i veri rivoluzionari – lo sappiamo – non sono privi né dell’una né dell’altra.
Daniele Ponchiroli, tratto da Ernesto Ferrero, I migliori anni della nostra vita
*
Nel libro di Calvino il dottor Cavedagna fa un’ultima confidenza: “Stanotte ho fatto un sogno, ero al mio paese, nel pollaio di casa mia, cercavo, cercavo qualcosa nel pollaio, nel cesto dove le galline fanno le uova, e cosa ho trovato? Un libro, uno dei libri che ho letto quand’ero ragazzo, un’edizione popolare, le pagine tutte sbrindellate, le incisioni in bianco e nero colorate da me, coi pastelli… Sa? Da ragazzo per leggere mi nascondevo nel pollaio…
Ernesto Ferrero, I migliori anni della nostra vita
*
A Daniele Ponchiroli
Italo Calvino, dedica del romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore

chiudi
|