
 |
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
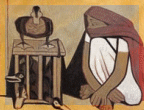 |
|||||||
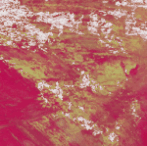 |
|||||||
 |
|||||||
| sitemap | |||||||

Dorothy Parker
“Le donne che lavoravano a Vogue erano persone semplici, non chic. Donne comuni, simpatiche – le donne più simpatiche che abbia mai conosciuto – ma non c’entravano niente con quel tipo di rivista lì. Indossavano cappellini eccentrici e sulle pagine della rivista verginizzavano le modelle trasformandole da tipe da sballo a deliziose fidanzatine. Ora le redattrici sono come dovrebbero essere, chic e mondane. La maggior parte delle modelle sembrano uscite dalla mente di uno come Bram Stoker, e chi scrive didascalie – il lavoro che facevo a quel tempo – consiglia di regalare fodere di visone a settantacinque dollari l’una per i manici in legno delle mazze da golf : ‘Per l’amico che ha già tutto’”. Nel 1917 sposa Edwin Pond Parker II, un agente di borsa del Connecticut, ma rimarrà legata soltanto al suo cognome perché ben presto i due divorzieranno (passate due settimane dalle nozze Edwin parte volontario per la Prima guerra mondiale, da cui torna dopo quindici mesi di permanenza in Europa con una forte dipendenza da alcol e morfina). “I nani uscivano dal circo e spaventavano Sherwood, che superava i due metri di altezza. Sbucavano alle sue spalle zitti zitti e gli chiedevano come fosse il tempo lassù. ‘Venite a farvi un giro?’, chiedeva a me e a Benchley, e noi smettevamo di lavorare e lo accompagnavamo a fare due passi. […] Io e Benchley eravamo abbonati a due riviste delle pompe funebri: The Casket e Sunnyside. […] Sunnyside aveva una rubrica umoristica intitolata ‘Dalla fossa alla riscossa’. Un giorno ritagliai una fotografia a colori che mostrava come e dove iniettare il liquido imbalsamatore e la appesi sopra la mia scrivania fino a quando Crowninshield non mi chiese di fargli la cortesia di toglierla. […] Sono consapevole che non ci comportavamo affatto bene. Uno dei redattori, Albert Lee, aveva sopra la sua scrivania una mappa piena di bandierine che indicavano dove stavano combattendo le nostre truppe durante la Prima guerra mondiale. Ogni giorno, dopo aver ascoltato le notizie, spostava le bandierine. Allora ero sposata, mio marito era oltreoceano, e poiché non avevo niente di meglio da fare mi alzavo una mezzoretta prima e andavo a spostargli le bandierine. Dopo un po’ arrivava Lee, guardava la mappa e si metteva a urlare perché era convinto che ci fossero le spie. Passava tutta la mattinata a rimettere a posto le puntine”. A Vanity Fair ricopre il ruolo di critica teatrale, e lo fa con tutta la sua ironica veemenza, non risparmia niente e nessuno, stronca attori e opere, definisce il teatro del tempo “un’autentica schifezza”, descrive per filo e per segno il comportamento del pubblico e sorvola sugli spettacoli: “Non so perché, ma per quanto un’opera di Oscar Wilde possa essere ben rappresentata, mi succede di essere più interessata al pubblico che alla commedia in sé. Nel pubblico di Wilde c’è qualcosa di indefinito che mi lascia sempre di stucco. Una finezza cosciente, un profondo apprezzamento della propria cultura. Gli spettatori trasudano un’atmosfera da ‘New Republic’, quell’aria da ‘io sono molto più snob di te’. ‘Ma guardateci’, sembrano dire. ‘Noi siamo gli intenditori. Siamo qui perché sappiamo apprezzare certe cose… non siamo come voi, povere zucche dure, che siete venuti solo perché non avete trovato posto al Giardino d’inverno.’ Avanzano lentamente lungo la corsia e si lasciano cadere con grazia sulla poltroncina, confidando che tutti possano notare la loro presenza, perché il semplice fatto di essere lì testimonia la loro erudizione. Dall’istante in cui si leva il sipario inizia il sommesso ronzio di approvazione. ‘Oh, le battute, che battute!’, sospirano uno all’altro, quasi come fossero i primi al mondo a scoprire che questo Oscar Wilde è un giovane autore molto promettente. E usano la parola ‘scintillante’ con frequenza e orgoglio, come se l’avessero coniata lì per lì. Eppure nel loro manifesto piacere c’è un certo non so che di stonato, come se ce la mettessero tutta per comportarsi come ci si aspetta che si comporti la gente al loro livello intellettuale. Non è il piacere che si esprime standosene seduti buoni e zitti ad ascoltare l’opera: è quasi come se fossero costretti a dover mostrare di continuo il loro apprezzamento, facendo vedere che nessun epigramma sfugge, convincendo i vicini della loro intelligenza e del loro gusto impeccabile in materia teatrale”. E ancora: “Spesso, nelle lunghe ore di pace e tranquillità, quando mi ritrovo bloccata in metropolitana, o seduta nella sala d’attesa del dentista, o mentre aspetto un autobus a Broadway, mi capita di riflettere con tristezza sui bei tempi andati, tempi che non torneranno mai più. Quelli sì che erano giorni felici… i giorni in cui il pubblico correva contento a teatro, si godeva ogni attimo dello spettacolo, applaudiva entusiasta, col desiderio che non finisse, e usciva inghirlandato di sorrisi a diffondere la lieta novella: ‘Uno spettacolo fantastico!’. Accadeva persino che qualcuno, di propria spontanea volontà, tornasse più e più volte a rivedere la stessa commedia. Ah sì, quelli erano bei tempi, non c’è dubbio.
Ma le sue stroncature, in particolare quella al fulmicotone in cui ridicolizza Billie Burke – moglie del produttore Florenz Ziegfeld – nella commedia La moglie di Cesare paragonandola a un’attrice di vaudeville, non piacciono ai produttori di Broadway, e il 12 gennaio 1920 viene licenziata. “In quel ristorante si crearono, a base di battute di spirito, di maldicenze diffamatorie e di derisioni (condotte sempre in assenza degli interessati), le voghe delle commedie e dei libri, dei personaggi pubblici e della moda. […] Il gruppo di recensori e critici, cronisti e giornalisti, agenti teatrali e direttori di riviste che frequentavano quel ristorante negli anni che precedettero la Prima guerra mondiale avevano un codice di comportamento e norme di contegno rigorose fino a meritare la pena capitale – l’espulsione – a chi non le rispettasse; ma per mafiose che fossero e per incanalate che fossero verso maldicenze denigratorie, almeno erano basate sull’invenzione e la creatività.” L’Algonquin diventa dunque il luogo di incontro dei migliori giornalisti del tempo, ma Dorothy non risparmia neanche loro: “La gente li ha romanticizzati… Non erano giganti. Pensate a quelli che stavano scrivendo a quei tempi: Lardner, Fitzgerald, Faulkner, Hemingway. Quelli sì che erano i veri giganti. La Tavola Rotonda dell’Algonquin non era che un gruppo di persone che si raccontavano barzellette ripetendosi fra loro che erano molto belle… Era il momento terribile della battuta, sicché non era necessario che dicessero cose vere… Quella gente della Tavola Rotonda non sapeva un accidente”. Nel 1926 pubblica la sua prima raccolta di poesie, Enough Rope, che contiene la celebre Resumé, in cui riflette sulle varie possibilità di suicidio: I rasoi fanno male, Nella sua vita Dorothy tenta almeno tre volte il suicidio: la prima, dopo essere rimasta incinta dell’aspirante commediografo Charles MacArthur, tagliandosi le vene col rasoio lasciato a casa dal marito, dopodiché comincia a bere e fumare a più non posso. Continua comunque a lavorare come critica teatrale per vari giornali, tra cui il Saturday Evening Post e il New Yorker (fondato nel 1925 da Harold Ross), per cui scrive recensioni di libri bellissime: “Credo che il Diario di Katherine Mansfield sia il libro più triste che abbia mai letto. In fragili, squisiti frammenti, c’è la memoria di sei anni solitari e tormentati, gli ultimi anni di una donna incurabilmente malata. Frammenti così privati che dopo averli letti ci si sente per sempre colpevoli del peccato di indiscrezione. Oppure: “Upton Sinclair si mette nei pasticci con le proprie mani. Non riesce a tenersi fuori dai suoi scritti, per quanto ci provi: o, in questo caso, per quanto non ci provi. Fategli iniziare un saggio su un argomento lontano mille miglia dai suoi interessi, e in mezzo minuto eccolo lì che spunta tra una frase e l’altra e ci racconta la storia di un torto lontano ma che ancora sanguina, o di qualche recente ingiustizia che è stata perpetrata nei suoi confronti. Il suo Money Writes! (Il quattrino impugna la penna!) è molto lontano dalla raccolta di accuse contro gli autori americani che, secondo quanto si mormorava, doveva essere; piuttosto si tratta di un’impetuosa accolita di lagnanze personali. Così com’è, è un documento interessante, ma non del tutto convincente. Leggendo il libro ci si trova nella condizione di poter scegliere tra due impressioni sull’autore così come si presenta oggi: o è vittima prediletta di delusioni e persecuzioni – e Dio sa che è stato preso di mira così crudelmente e in modo così totale che era quasi inevitabile immaginare una vasta cospirazione nei suoi confronti. Oppure è diventato una lagna fatta e finita. Molti socialisti, e lo dico nonostante sia anima e corpo per la causa del socialismo, fanno questa fine […]”. Sempre sul New Yorker il 29 ottobre 1927 parla di Ernest Hemingway: “Lo stile di Hemingway, la sua prosa scarnita fino all’ossatura giovane e salda, è assai più d’impatto, assai più commovente nei racconti che non nel romanzo. E, a parer mio, Hemingway è il più grande autore vivente di racconti; e, sempre a parer mio, non è il più grande romanziere vivente. […] Hemingway è un genio perché dispone di un infallibile senso selettivo. Elimina i dettagli con munifica prodigalità; tiene le parole al piccolo trotto. Come ogni lettore sa, è un’influenza pericolosa. Le semplici cose che fa sembrano così facili da imitare. Ma guardate un po’ come se la cavano quei tizi che ci hanno provato”. Nel 1929 un suo racconto, Big Blonde (Una bella bionda), esce sulla rivista letteraria The Bookman, e le permette di vincere il premio O. Henry per il miglior racconto dell’anno. È un vero e proprio capolavoro sulla solitudine femminile nella grande città, di cui W. Somerset Maugham scriverà che “è degno di prendere il suo posto tra i racconti, e sono pochi, che si ricordano per molti, moltissimi anni. Mostra alla perfezione tutti gli invidiabili talenti di Dorothy Parker. Poche cose sono più difficili di scrivere un racconto che si svolge in un lungo periodo di tempo, mantenendo quell’unità che è l’essenza stessa del racconto breve. […] Dorothy Parker ci è riuscita con particolare abilità, tanto che nonostante il trascorrere degli anni mantiene la stessa pregnanza che in genere è possibile solo nel narrare un singolo avvenimento. Credo sia il risultato di una precisa concentrazione su quella sgualdrinella patetica, inetta, disperata, tragica e sciatta che è Hazel Morse”.
Nei suo racconti Dorothy raffigura le frivolezze, le idiosincrasie, i vizi della società americana e, come sottolinea il New York Times, “deride le ossessioni dell’alta società e raccoglie un’affilata collezione di debolezze umane”. “In una scenetta o in un racconto, lei sa esattamente dove iniziare e dove finire, e una volta terminata la lettura non ti restano domande insolute (e poi cos’è accaduto? perché l’ha fatto?), perché lei ti ha raccontato tutto quel che c’era da sapere. Ha una mente ordinata, e non lascia fili sospesi. Possiede un orecchio sorprendentemente fine per la conversazione umana e con poche parole di dialogo, che sembrerebbero scelte a caso, è capace di rendere una personalità completa in tutta la sua improbabile plausibilità. Il suo stile è semplice, senza essere trasandato, e colto senza essere affettato. È uno strumento perfetto per esprimere il suo umorismo multiforme, la sua ironia, il suo sarcasmo, la sua tenerezza, il suo pathos. Forse ciò che dà alla sua scrittura il sapore caratteristico è la capacità di vedere il lato ridicolo anche nelle più amare tragedie della bestia umana”. Alcuni sono brevi bozzetti, come il magnifico Benvenuti a casa che ritrae una tipica coppia newyorkese (pubblicato nel Saturday Evening Post il 22 luglio 1922; in Italia edito da Bur nella raccolta Giochi di società, 2013, traduzione di Chiara Gabutti): “Se un giorno o l’altro vi capitasse di andare alla ricerca di una tipica coppia newyorkese, non potreste capitare meglio che con i miei amici Lunt. Più tipici di così non si può.
Nel 1933 sposa l’attore e scrittore Alan Campbell, un uomo attraente e più giovane di lei di undici anni – sarà lui a ispirare il protagonista di Tenera è la notte di Francis S. Fitzgerald –, con cui comincia a scrivere sceneggiature per Hollywood e da cui divorzierà nel 1947 (lo risposerà nel 1950 per separarsi di nuovo tre anni dopo, anche se i due rimarranno vicini fino alla morte di lui avvenuta nel 1963). Si trasferisce a Hollywood, di cui anni dopo dirà al Paris Review: “Il denaro di Hollywood non è denaro. È neve ghiacciata che ti si scioglie in mano. Non posso parlare di Hollywood. È stato orribile stare lì ed è orribile ripensarci adesso. Non so come ho fatto. Quando me ne sono andata non riuscivo nemmeno a pronunciarne il nome. ‘Quel posto là’, lo chiamavo”. “Lolita, come senza dubbio sapete, ha passato un bel po’ di guai, scatenando un pandemonio infinito. […] Non credo che Lolita sia un libro sudicio. Non riesco a considerarlo come pornografia, pura, senza limiti, o di qualsiasi altro genere. È la storia coinvolgente, angosciosa di un uomo, un uomo di gusto e cultura, che riesce ad amare solo le bambine. Devono avere un’età compresa tra i nove e i quattordici anni, e lui le chiama ninfette. […] È un libro angoscioso, ma a volte sfrenatamente divertente, come nella saga del viaggio del protagonista per tutti gli Stati Uniti, con la bambina, in cerca di un luogo che possa piacerle; e nel resoconto di quel pellegrinaggio ci sono descrizioni del retroterra americano che Sinclair Lewis non avrebbe mai raccontato. […] È nella scrittura che Nabokov ha creato un’opera d’arte. Nabokov, sapete, lo stesso tizio che ha scritto i racconti delicati in Pnin, ha iniziato a scrivere in inglese molto dopo aver passato la prima giovinezza. La sua padronanza della lingua è assoluta, e Lolita è un bel libro, un libro che si distingue. E va bene: un grande libro”. O quella su Abbiamo sempre vissuto in un castello di Shirley Jackson del dicembre 1962: “E per noi il sole continua a splendere. Il miracolo è opera di Shirley Jackson, Dio la benedica, come sempre mai eguagliata, e men che mai nella sua ultima opera, Abbiamo sempre vissuto in un castello, come leader nel campo dei brividi magnificamente scritti, calmi, ridondanti. Fervente sostenitrice dei diritti civili, Dorothy si proclama comunista anche se non si iscrive al partito e contrae “il virus rivoluzionario durante la campagna in difesa di Sacco e Vanzetti e da allora non ha più abbandonato l’impegno politico. Fa di tutto per sensibilizzare gli americani sui pericoli del nazismo, attraverso la Hollywood Anti-Nazi League, si abbona al Moscow News e si iscrive a tutto, prestando il suo nome ormai famoso a ogni causa: i Friends of the Abraham Lincoln Brigade, la Southern Children’s Milk Fund. Ovviamente negli anni Cinquanta sfida con entusiasmo la commissione del senatore Joseph McCarthy, ma avrà l’umiliazione di non essere presa troppo sul serio. Forse perché ha sempre fatto divertire i lettori” (Cristina De Stefano, Americane avventurose, Adelphi, 2007). Muore il 7 giugno 1967 per una crisi cardiaca nella camera d’albergo dove viveva, lasciando tutti i suoi averi a Martin Luther King. Sulla sua lapide l’epitaffio: “Scusate la polvere”. * Amico, a te un consiglio salutare,
|




