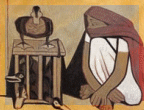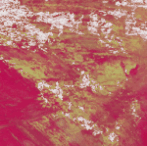Mary Frances Kennedy Fisher
M.F.K. Fisher: la nostra poetessa degli appetiti.
John Updike
*
È stata la pioniera americana del food writing. Invenzione raffinata – parlare di cibo per parlare d’altro –, che l’ha resa famosa e al tempo stesso l’ha penalizzata dal punto di vista letterario. Sarebbe potuta essere una grande scrittrice – e per qualcuno lo era: Auden, ad esempio, la definì la più grande prosatrice americana del secolo –, ma per certi critici restava prigioniera di quella colpa originaria: scrivere solo di cucina, anziché di amore o di guerra. Lei ne rideva, sinceramente divertita: «Secondo me, i tre bisogni fondamentali dell’uomo – cibo, amore, sicurezza – sono così strettamente legati che è impossibile pensare a uno di essi senza pensare anche agli altri». Prima che della cucina, in effetti, i suoi libri parlavano della vita: di viaggi, amori, incontri, colori, profumi. E di sapori, certo, e di ricette, ma posate qua e là casualmente, «come uccelli su un albero, quando trovano un ramo comodo», spiegava. Sono strani libri inclassificabili che contengono frasi come questa: «L’ostrica conduce una vita spaventosa, ma palpitante». O questa: «Probabilmente la cosa più segreta al mondo, finché non lo si è rotto, è un uovo». Libri che parlano di come essere belli in cucina (prima di tutto appendendo al muro uno specchio, come faceva lei nella sua), di come scacciare la malinconia con tre arance (da sbucciare con delicatezza in forma di fiore e mettere a seccare sul calorifero), dello status sociale delle verdure, del sale contenuto nelle lacrime, della saggezza del nostro corpo, che anche nella disperazione continua a vivere. «Anche nell’angoscia della morte e del dolore e delle brutture resta la fame, e insieme alla fame la vira, con tutta la sua pace. Come se i nostri corpi, più saggi di noi, ci incoraggiassero, contro di noi e quello che abbiamo imparato, e ci costringessero a rispondere, e a mangiare».
Sa di cosa parla, Mary Frances Kennedy Fisher. […] Nata nel 1908 in una bella famiglia rumorosa, in continuo movimento verso il West – «si sarebbe potuta definire una famiglia di hippy, se il termine non fosse stato inventato molti anni dopo» dirà lei stessa –, cresce felice in grandi fattorie piene di orti, vigneti, animali da cortile. […] Scopre presto le sue due passioni: cucinare e scrivere. In casa è famosa per le petizioni in versi ai genitori. D’estate, quando i redattori sono in vacanza, aiuta il padre, che dirige un giornale locale, e a furia di correggere bozze e temperare matite impara la punteggiatura. […] Sposa Al Fisher, un giovanotto che vuol terminare gli studi di letteratura a Digione, lo segue in Europa e scopre un altro mondo. Tutto, durante il suo soggiorno in Francia, la incanta: «In quel Paese imparai a fare l’amore, a mangiare, a bere, e a essere me stessa e non quello che gli altri si aspettavano che io fossi». Per essere perfettamente felice – «una donna nutrita in tutti i suoi appetiti» – le manca solo un amore perfetto, un uomo con cui condividere queste scoperte. E quando, nel 1932, conosce il pittore Dillwyn Parrish, detto Timmy, capisce di averlo finalmente trovato. Anche lui è sposato, e all’inizio il loro non è un rapporto facile. Ma nel 1936 riescono ad andare a vivere insieme in Europa, e due anni dopo a sposarsi. Cercano un posto tranquillo dove lui possa dipingere e lei scrivere, perché, incoraggiata da Timmy, ha iniziato a lavorare al suo primo libro. La scelta cade su una grande casa vicino a Vevey, in Svizzera. La comprano e iniziano subito a trasformarla. Deve essere la loro casa, costruita intorno alle loro vite come una conchiglia. Con grande scandalo dei vicini fanno abbattere il muro della cucina per metterla in comunicazione con il soggiorno, in modo che la musica e le chiacchiere e i profumi si muovano liberamente da una parte all’altra. Intorno alla casa piantano un grande giardino, con l’orto e la vigna. […] Nel 1939, durante una gita a Berna, Timmy è colpito da un embolo. I medici gli salvano la vita ma devono amputargli una gamba. È l’inizio di un lento martirio. […] Timmy è come pazzo dal dolore, e meno di un anno dopo si toglie la vita, dopo averne parlato lungamente con Mary. […] L’unico rifugio possibile è la scrittura. Conclude il libro che stava scrivendo per distrarre Timmy dalla malattia, quella Biografia sentimentale dell’ostrica che la renderà famosa. E poi continua a scrivere. Un libro ogni anno, per anni. E a collaborare con i giornali. Nel 1943 va perfino a Hollywood a cercare fortuna come sceneggiatrice. Da questa trasferta riporterà a casa una figlia, Anne, nata nel 1943. Del padre non vorrà mai dire niente, neanche agli amici più cari, e per tutti la piccola sarà sempre, ufficialmente, una figlia adottiva. «Questa bambina è la cosa giusta, in ogni senso» scrive solo, in una lettera. «Ora la mia vita sembra piena e calda e ricca di nuovo. Sono stata fuori al freddo per tanto tempo…». A parte Anne, a parte pochi amici speciali, tra cui i fratelli Marx, di Hollywood non ha un buon ricordo. Scrive delle battute per Bob Hope e Bing Crosby, ma il suo umorismo è troppo raffinato per funzionare al cinema. E lei troppo brava per essere credibile. Non rilegge mai quello che scrive. Pensa direttamente per frasi intere, per paragrafi. In un’intervista ricorderà: «Un produttore mi disse: voglio una gag di tre minuti. Io tornai nel mio ufficio, la dettai alla segretaria e gliela feci portare. Quando la lesse lui sbottò: non è possibile, l’ha copiata, nessuno può scrivere una cosa simile in cosi poco tempo. E la rifiutò».
Finita la guerra si trasferisce con la figlia a New York, dove accetta la corte del suo nuovo editore, Donald Friede, e in sole due settimane lo sposa. Metteranno al mondo un’altra bambina, Kennedy, ma durerà poco. «Ero la sua quinta moglie, fu un matrimonio corto e sciocco, ma allegro» riassumerà lei in un’intervista. Da quel momento in poi cresce da sola le figlie, spostandosi con la regolarità di un metronomo tra la Francia del Sud e la California, dove si è costruita un piccolo ranch nella Napa Valley. Scrive sempre moltissimo, anche se ormai è così famosa che potrebbe smettere e vivere dei diritti d’autore. […] Soprattutto, osserva la sua vecchiaia con attenzione, per affrontare appieno anche questa prova. Alla vecchiaia dedica un libro, Sister Age: «Penso che si debba darle il benvenuto. E io le do il benvenuto come a una sorella». […] Muore nel 1992, a ottantaquattro anni.
Cristina De Stefano, Americane avventurose, Adelphi, 2007, pp. 77-82
*
Quando non posso lavorare leggo, quando non posso leggere cucino.
M.F.K. Fisher
*
L’ostrica conduce un’esistenza terribile e al contempo eccitante. Tanto per cominciare, le possibilità che venga al mondo sono minime. Ma se ce la fa, se sopravvive agli strali del suo stesso, stravagante destino e se nelle due settimane della sua spensierata giovinezza trova un appiglio liscio e pulito a cui aggrapparsi, la sua vita adulta sarà una girandola di passioni e pericoli. […]
Esistono tre categorie di mangiatori d’ostriche: i tipi dalla mentalità aperta che le mangerebbero in tutti i modi, calde, fredde, vive, morte, in brodo o in zuppa, basta che siano ostriche; quelli che le mangiano solo e soltanto crude e quelli che, con lo stesso rigore, le gustano cotte e in nessun altro modo.
La prima categoria è forse quella che se la gode di più sebbene l’integralismo degli altri due gruppi sia alimentato da un fuoco sacro che mai scalderà le mentalità più tolleranti.
A favore della seconda categoria ci sarebbe molto da dire, dal momento che quasi tutti i mangiatori di ostriche, esclusi appunto i più convinti adepti del terzo e ultimo gruppo, si toglierebbero la vita piuttosto di negare che un’ostrica perfetta, sana, di buon sapore, prelevata dal suo gelido letto e servita senza essere stata lavata né condita, sia più deliziosa di qualunque variante cucinata. D’altra parte un esemplare flaccido, molle, sfiancato dagli eccessi amorosi e con i nervi a pezzi a causa della situazione del mondo farà un’impressione davvero pietosa servito crudo nella sua conchiglia.
E a questo punto che il terzo gruppo, i fanatici sostenitori dell’utilità del calore e delle salse per nascondere una moltitudine di difetti reali o immaginari, sale trionfante alla ribalta. Qualsiasi ostrica, persino una giapponese bastarda, prelevata lungo le coste dell’Oregon, cotta al vapore e inscatolata, può sprizzare buonumore e gioia di vivere quando è, come dicono, “ben vestita”. E hanno ragione.
Questa teoria non funziona per chi non si fida del detto “occhio non vede cuore non duole”, perché in tal caso qualsiasi ostrica cucinata diventa sospetta e la buona, vecchia ptomaina sembra starsene acquattata dietro ogni casseruola e scaldavivande.
Funziona, invece, in quanto la necessità di inventare camuffamenti ha generato una profusione di raffinate, ingegnose ricette, un po’ come i giorni di magro nel Medioevo costrinsero le menti più geniali della Chiesa a concepire stratagemmi per fare in modo che uova e formaggio sapessero di vitello arrosto. Alcune delle ricette per cucinare le ostriche sono molto semplici e altrettanto deliziose, altre follemente complicate come i gourmet biliosi e sfiniti che le hanno concepite.
Uno dei piatti più semplici e saporiti in cui potete cimentarvi, se ne avete voglia, è quello delle ostriche al forno. È un’ottima ricetta, che potete chiamare un po’ come volete, ostriche al gratin, pasticcio di ostriche ecc.
Ostriche al forno
Cospargete una teglia bassa e ben imburrata con un leggero strato di briciole di pane o di cracker. Stendete quindi uno strato di ostriche condite con sale, pepe macinato al momento e riccioli di burro. A questo punto disponete un altro strato di briciole e continuate così, finché la teglia non sarà quasi piena, terminando con briciole e riccioli di burro. Inumidite il tutto con il liquido delle ostriche e passate un attimo in forno finché non saranno dorate, evitando però che inizino a bollire.
Su questo tema chiunque, persino un cuoco principiante o assillato dalla fretta, si può sbizzarrire in infinite varianti: cipolla affettata, salsa di pomodoro, erbe aromatiche, senape, panna troveranno in questa ricetta un rifugio assolutamente sicuro.
Un altro metodo facilissimo per cucinare le ostriche, quello adottato dalla maggior parte dei ristoranti, consiste nel friggerle. È una soluzione squisita e tuttavia tanti chef immergono le ostriche in una densa e spesso ignominiosa pastella che, gettata in un grasso altrettanto osceno, forma un involucro vischioso e tenace in cui l’ostrica langue impotente, fumante nella sua ripugnante prigione, senza sapore eppure del tutto indigesta.
I molluschi freschi e sodi, passati rapidamente nel pangrattato, immersi per un istante in un buon grasso bollente e serviti immediatamente su un vassoio caldo con una semplice salsa tartara o qualche spicchio di limone, possono invece rappresentare uno dei piatti migliori che si possano gustare un po’ dappertutto, e il fatto che io ne sia ancora convinta nonostante i miei numerosi, orribili incontri ravvicinati con ostriche fritte nei ristoranti è forse la dimostrazione che l’ottimismo è innato negli esseri umani.
M.F.K. Fisher, Biografia sentimentale dell’ostrica, Neri Pozza, 2005

chiudi
|