
 |
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
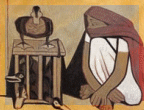 |
|||||||
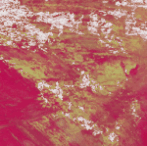 |
|||||||
 |
|||||||
| sitemap | |||||||


Maeve Brennan Era bellissima. Sofisticata, inquieta. “Era una donna minuta, affascinante, generosa e spiritosa, anche se non si sforzava affatto di esserlo; aveva occhi verdi, portava occhiali enormi con la montatura di corno e i capelli castani cotonati e raccolti in un’acconciatura simile a un grosso alveare.” La ricorda così William Maxwell, suo editor al New Yorker, oltre che caro amico e mentore. Maeve Brennan è tra le signore della letteratura irlandese – della forma breve in particolare. Nasce a Dublino il 6 gennaio del 1917, mentre il padre Robert, militante repubblicano, è in galera per aver preso parte alla Rivolta di Pasqua. Maeve è figlia della rivoluzione dunque, e può conoscere il padre solo a cinque anni. Con la madre Una, le due sorelle e il fratello, vive a Dublino, nel quartiere Ranelagh, sulla Cherryfield Avenue: From the time I was almost five until I was almost eighteen, we lived in a small house in a part of Dublin called Ranelagh. On our street, all of the houses were of red brick and had small back gardens, part cement and part grass, separated from one another by low stone walls over which, when we first moved in, I was unable to peer, although in later years I seem to remember looking over them quite easily, so I suppose they were about five feet high. All of the gardens had common end walls, which was, of course, very long, since it stretched the whole length of our street. Our street was called an avenue, because it was blind at one end, the farthest from us. It was a short avenue, twenty-six houses on one side and twenty-six on the other. We were at No. 48, and only four houses from the main road, Ranelagh Road, on which trams and buses and all the kinds of cars ran, making a good deal of noisy traffic. Scampato alla pena di morte, Robert Brennan esce di prigione ma è uno dei bersagli della polizia dello Stato libero. Si nasconde in posti diversi, sicuri, non vuole mettere in pericolo la moglie e i figli. In un racconto intitolato “The Day We Got Our Own Back” e pubblicato sul New Yorker del 24 ottobre del 1953 (confluito poi in The Springs of Affection), Maeve ricorda: “He was on the run, sleeping one night in one house and the next night in another, and sometimes stealing home to see us. I suppose my mother must have taken us to see him several times, but I only remember visiting him once, and I know I found it very odd to meet him sitting in a strange person’s house, and to leave him there when we were ready to go home”; e prosegue descrivendo due incursioni da parte degli uomini del governo nella sua casa di Dublino, in cerca del padre; il primo raid: One afternoon some unfriendly men dressed in civilian clothes and carrying revolvers came t our house searching for my father, or for information about him. This was in Dublin, in 1922. […] They crowded into our narrow little hall, and tramped around the house, upstairs and downstairs, looking everywhere and asking questions. There was no one at home except my mother, my little sister Derry, and me. Emeer, my elder sister, and my mother’s chief prop, was out doing errands. I was settled comfortably on a low chair in our front sitting room, threading a necklace. I was five. Il secondo raid, più sconvolgente: The only other raid I remember took place about a year after that, and the men were rougher. Again there in the house only my mother, my little sister, and I. This time, the men came in the morning. My mother was getting along with her housework, and she had an apron tied about her waist. She had shined the brass rods that held our red stair carpet in place, and now she was polishing the oilcloth on the dining-room loor. The men crowded in as before, with their revolvers, but this time they searched in earnest. They pulled all the beds apart, looking for papers and letters, and they took all my father’s books out of the shelves and shook them, and they looked in all the drawers and in the wardrobe and in the kitchen stove. There was not an inch of the house they did not touch. They turned every room inside out. The newly polished oilcloth was scarred by their impatient feet, and the bedrooms upstairs were torn apart, with sheets and blankets on the floor, and the mattress all humped up on the bare beds. In the end they went back to the kitchen and they took down the tins of flour and tea and sugar and salt and whatever else there was, and plunged their hands into them and emptied them on the table and on the floor. Still they had found nothing, but the house looked as though it had suffered an explosion without bursting its walls. * Nel 1934 i Brennan lasciano Dublino – Maeve ha diciassette anni, studia al cattolico Cross and Passion College di Kilcullen (di cui parlerà in alcuni racconti piuttosto ironici come “The Devil in Us” e “Lessons and Lessons and Then More Lessons” pubblicati sul New Yorker) e scrive per l’Irish Press fondato, tra gli altri, dal padre –, si imbarcano sulla Manhattan e si trasferiscono negli Stati Uniti: Robert è infatti nominato primo rappresentante della repubblica d’Irlanda a Washington. E negli Stati Uniti Maeve rimarrà per il resto della sua vita.
Maeve lavora senza sosta, è infaticabile. E scrive. Scrive di New York negli editoriali e di Dublino nei racconti, della città americana scintillante e al tempo stesso minacciosa e della claustrofobica patria cattolica. I pezzi per “The Talk of the Town” sono schizzi di varia natura, alcuni descrittivi altri più introspettivi, focalizzati su dettagli, eventi e aspetti minimali della vita, ambientati in ristorantini, piccoli alberghi, negozietti, popolati da creature avvinte dalla solitudine e alle prese con problemi di accettazione sociale, con la cecità del mondo. “Parlano sempre di New York: di un temporale osservato dalla finestra di un appartamento in prestito, di un uomo sempre colto nell’atto di pettinarsi, di un cane maleducato, dell’invisibilità, di ascensori automatici che cigolano e si muovono come se fossero poco sicuri e spesso si fermano al piano sbagliato, della luce del cielo in un determinato momento del giorno, di una parte della città con un’atmosfera di caducità e sciatteria, dei pensieri di persone viste una sola volta oppure immaginarie, di una gabbia piena di minuscoli uccellini in vendita nel seminterrato di un negozio dove tutto costa cinque e dieci cent, dell’apprensione nata da cause sconosciute, di un giovanotto che aspetta la fidanzata nel bar di quello che poi si rivela essere l’albergo sbagliato, di ciò che si nasconde dietro la curiosità che la spinge a leggere per prime, sul giornale del mattino, le pagine dei necrologi”, come ricorda Maxwell (dalla prefazione alla racconta Il principio dell’amore di Maeve Brennan, edita in Italia da Bur, 2006).
Quarantasette di questi editoriali scritti tra il 1953 e il 1968 vengono pubblicati nel volume The Long-Winded Lady nel 1969, tra cui un fulminante “Scelta dolorosa” (che risale al 18 settembre 1954): L’altra sera mi trovavo in un nuovo, piccolo supermarket e aspettavo che mi sistemassero gli acquisti in un sacchetto, quando ho visto un uomo alto e trasandato con gli occhi rossi, che di certo beveva come una spugna sin dall’infanzia, cercare di decidere tra un barattolo di fagioli, un pranzo in scatola, una minestra in scatola e uno spezzatino di pollo in scatola. Aveva 37 centesimi, oppure 29, una cifra del genere, e se ne stava lì in piedi con quei quattro barattoli, li fissava e poi guardava le bancarelle di frutta, verdura, pane e così via. Non riusciva a decidersi cosa comprare per nutrirsi ed era chiarissimo che in realtà non voleva affatto del cibo. Ho pensato che non l’avrei biasimato se avesse rimesso le scatole sugli scaffali, o le avesse lasciate cadere sul pavimento e si fosse precipitato nel bar più vicino, dove avrebbe potuto semplicemente ordinare una birra e bersela. Poi mi è venuto in mente che, per dirla in maniera un po’ semplicistica, in genere esiste una sola cosa che desideriamo fare e che ci fa male, mentre se ci sforziamo di compiere gesti buoni o virtuosi la scelta è così grande e ampia che alla fine ci stanchiamo prima ancora di decidere. Voglio dire che l’impulso verso il bene implica una scelta complicata, mentre l’impulso al male è odiosamente semplice e facile. Mi dispiace per quel povero uomo alto con gli occhi rossi. Ad aprire il volume c’è la nota dell’autrice, che parla della signora prolissa, di sé stessa: […] Now when I read through this book I seem to be looking at snapshots. It is as though the long-winded lady were showing snapshots taking during a long, slow journey not through but in the most cumbersome, most reckless, most ambitious, most confused, most comical, the saddest and coldest and most human of cities. Sometimes I think that inside New York there is a Wooden House struggling desperately to get out, but more often these days I think of New York as the capsized city. Half-capsized, anyway, with the inhabitants hanging on, most of them still able to laugh as they cling to the island that is their life’s predicament. * La centralità di New York nei suoi editoriali viene apprezzata da John Updike in una recensione a The Long-Winded Lady pubblicata nel 1969 sull’Atlantic (in Italia, è la postfazione alla raccolta Racconti di New York, Bur, 2010): “A Maeve Brennan […] va il merito di aver riportato New York al New Yorker, descrivendo la città degli anni Sessanta con onestà e affetto. […] la Brennan è costantemente all’erta, la vista acuta di un passero, attenta alle briciole della realtà, a quanto udito per caso, visto di sfuggita, ipotizzato […]. È una sobria ma formidabile cesellatrice di frasi, come nella sua lunga poesia sull’ailanto (che non chiama mai ‘albero del paradiso’) o in quell’immagine della ‘luce del giorno che scorre come acqua fredda’ sulle scale curve e le pareti tappezzate di case diroccate in arenaria rossa. Poco alla volta dai suoi scritti sedimenta un ritratto malinconico delle strade di New York: ‘La vista notturna sulla Sesta Avenue è inquietante ora che gli isolati sul lato ovest della via sono stati per metà abbattuti e per metà abbandonati. […] [Charles] è una strada affascinante, se non fosse che di notte, come accade a tutte le viuzze di New York, le tocca indossare un’aria desolata e minacciosa a causa delle file e file di auto posteggiate lungo i marciapiedi: auto bloccate, in coda, che le rubano ogni particella di vita e di spazio. […]’”.
Nel 1954 Maeve sposa St Clair McKelway, scrittore e reporter del New Yorker, donnaiolo, alcolista e maniaco depressivo, alle sue quarte nozze e più grande di lei di dodici anni. Maeve non finisce in braccia protettive. E difatti il matrimonio si sfascia dopo cinque tempestosi anni, anche se i due si lasciano senza rancori. Maeve non si risposerà più. Vivrà da sola, cambiando con frequenza dimora.
Eccoli Rose e Hubert Derdon: […] la cosa peggiore che Hubert ricordava di quel giorno infelice era l’espressione di terrore che aveva attraversato il viso di Rose quando lui le aveva parlato in modo brusco. Era rimasto colpito dal terrore e dal dolore che le aveva letto in faccia. Si era limitato a risponderle male, colto da un’irritazione e da un’impazienza naturali – così si giustificava con sé stesso – ma lei aveva reagito come se fosse stata calpestata. Bastava un niente a metterla in ginocchio. Aveva davanti il piatto pieno, ma mangiava pochissimo e se ne stava a testa bassa come una bambina in castigo o un cane punito, furtivo. Poi l’aveva lasciata a lavare i piatti e quand’era tornato in cucina, dopo aver riacquistato il controllo, per suggerire la gita al parco, l’aveva trovata in piedi davanti all’acquaio a finire ciò che aveva lasciato nel piatto, e quando era apparso sulla porta, lei si era girata in preda al panico per nasconderlo, per nascondere ciò che stava mangiando, e lui le aveva voltato le spalle ed era tornato di sopra, fingendosi di non essersi accorto di nulla.
Ed ecco cosa accade nella casa di Delia e Martin Bagot: In casa la situazione era innaturale, nessuno teneva realmente in considerazione gli altri. Quando Martin era in casa, lei diventava molto nervosa con le bambine, e quand’erano tutti insieme, non riusciva a impedirsi di tenerle d’occhio, come se Martin fosse lì soltanto per giudicarle. Era sempre tesa, pronta a difenderle da lui, pronta a prendersi la colpa di ciò che facevano, e pronta a rimproverarle bruscamente se accennavano a fare qualcosa che avrebbe potuto irritarlo. * (I racconti della Brennan sono molto amati da due maestre di short story, entrambe canadesi: il premio Nobel Alice Munro che definisce Il principio dell’amore “uno dei miei preferiti tra i racconti di tutti i tempi” e Mavis Gallant che considera le sue storie “vere e incantevoli”. Anche Paula Fox ne sottolinea il vigore: “I racconti della Brennan sono irresistibili. È una qualità difficile da esprimere. Com’è possibile descrivere il vigore della sua lingua, la sua stupefacente freschezza?” – dalla prefazione a La visitatrice, Bur, 2005 –; e Claire Messud parla di eleganza e precisione, di prosa tagliente, per lei leggere i racconti di Maeve è “puro piacere letterario”. * Dopo la fine del matrimonio, Maeve cambia di continuo, intenzionalmente, casa. Trasloca di albergo in albergo, portandosi dietro i suoi amatissimi gatti e il labrador nero, Bluebell. Nel brano “Faraway Places Near Here”, contenuto in The Long-Winded Lady, fa un elenco dei principali alloggi avuti fino al 1962: Sullivan Street, Hudson Street, Tenth Street, Twenty-second Street vicino alla Ninth, Ninth Street vicino alla Fifth, Hotel Earle nel Village e così via. D’altronde, l’idea di casa come nido, come luogo stabile, di conforto, non le è mai appartenuta, compromessa nell’infanzia – nella novella La visitatrice Anastasia-Maeve definisce la casa “un luogo della mente”. Mary Ramsay, voce ruvida, mani ruvide in tutti i modi possibili. Con quella lingua ti scorticava vivo, dicevano all’hotel. Tutti avevano paura di lei. * William Maxwell ricorda così l’ultimo cupo periodo della sua amica: “Negli ultimi dieci anni della sua vita entrò e uscì dalla realtà in un modo che spezzava il cuore a guardarla e che soltanto gli ospedali potevano affrontare. Molti anni prima aveva scritto sulla parete del mio ufficio, sotto la citazione di Yeats: ‘Un certo grado di autostima è necessario perfino ai pazzi. Conrad’”. Caro William Si tratta delle nostre vite—
E Maeve non ce la fa. I nervi la abbandonano.
|




