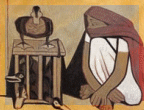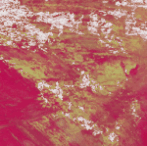Ingeborg Bachmann
“Scriveva poesie. Ciò stupì un poco gli amici. La sua mente raziocinante l’aveva fatta apparire più incline alla saggistica. Inoltre quegli anni erano particolarmente antieroici, antipoetici. Predominava il discorso, trionfava la frase più scarna possibile. Eppure Ingeborg covava una liricità che nulla aveva a che fare col ragionamento. Cantava, trasformando il pensiero in immagini che solcavano la pagina, a grappoli, con parole di fuoco. Tutte le più strane combinazioni potevano avvenire in mezzo ai versi: irruzione di sgomento e colpa, ammonizioni, verdetti, tragiche consapevolezze, estasi nei confronti della parola.”
Grazia Livi, Le lettere del mio nome, La Tartaruga
*
Così parlò
e la luce
si spense,
scrisse, e
un uomo cadde a pezzi
come un vestito vecchio.
La tortura
*
Dalla terrazza più alta
volevo saltare,
sono salita a piedi
lungo la scala di servizio, per
i domestici, e ho origliato
alla porta le risate
nelle mie stanze, mi hanno scoraggiata. Un cadavere,
subito dopo colazione, lo avresti
preso male
Sulla terrazza più alta
*
Andai dunque nel deserto. La luce si rovesciò su di me, l’eruzione del cielo, il suo odore nitido, ardente, mi è divenuto familiare. Sono fuggita, anzi mi sono ribellata, allontanata dalla clinica, mentendo ho fatto sparire le mie tracce, mi sono procurata il siero con dei pretesti, ho simulato che la vista si annebbiasse e di poter stare a galla, senza dover annaspare con le braccia, ho falsificato i referti. Non c’è più bisogno di menzogne qui, tutti guardano fisso dinanzi a sé, tutti hanno uno sguardo che non promette più nulla.
da Il libro Franza, Adelphi
*
Ma non vogliamo parlare dei limiti,
e limiti attraversano ogni parola:
spinti dalla nostalgia li oltrepasseremo
e poi saremo in armonia in ogni luogo.
Von einem Land, einem Fluss und den Seen
Il compito dello scrittore non può consistere nel negare il dolore,
nel nascondere le tracce, nel far nascere illusioni su di esso. Per lui
anzi il dolore deve essere vero e deve essere reso tale una seconda volta,
cosicché noi possiamo vederlo. Tutti, infatti, vogliamo diventare
vedenti. E solo quel dolore nascosto ci fa sensibili all’esperienza
e soprattutto all’esperienza della verità. Quando siamo in
questo stato in cui il dolore diventa fertile, stato che è insieme
chiaro e triste, noi diciamo, molto semplicemente, ma a ragione: mi si
sono aperti gli occhi. E non lo diciamo perché abbiamo davvero
percepito esteriormente un oggetto o un avvenimento, ma proprio perché
comprendiamo ciò che non possiamo vedere. E l’arte dovrebbe
portare a questo. Far sì che, in tal senso, ci si aprano gli occhi.
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar
Alla poetessa austriaca, nata a Klagenfurt nel 1926, gli occhi si sono
aperti in Italia, a Roma.
Ho visto che dicendo Roma si evoca ancora il mondo e che la chiave della
forza sono quattro lettere S.P.Q.R. […] Qui a Roma il Tevere è
bello, ma trascurato. L’isola Tiberina è un’isola di
malati e di morti. Al Ghetto non bisogna lodare il giorno prima che faccia
sera. […] Giordano Bruno continua ad essere bruciato ogni sabato,
quando si smantella il mercato. A Roma ho visto che tutto ha un nome e
ho capito che bisogna conoscere i nomi.
Quel che ho visto e udito a Roma
Arrivata a Roma, quasi per caso, nell’autunno del 1953 e senza poter
spiegarne il vero motivo Ingeborg Bachmann ci rimase fino alla sua morte
precoce nel 1973. A differenza della maggior parte degli scrittori tedeschi
o austriaci che arrivano in Italia sulle tracce di Goethe e con lo sguardo
nordico di chi ammira i monumenti e la storia, per la Bachmann vivere
in Italia fu una cosa naturale e non sentì il bisogno di tematizzare
e di citare Roma nelle sue opere. Anzi, diceva di avere una “doppia
vita” abitando nel cuore di Roma e scrivendo opere ambientate a
Vienna. Per lei Roma fu una “città aperta con un carattere
utopico”, una “città a strati” dove riuscì
semplicemente a trovare una “sensazione di patria intellettuale”.
In questa Roma dal carattere utopico lavorò ininterrottamente al
ciclo Todesarten (Modi di morire), una serie di romanzi che dovevano
avere come tema la morte dovuta alla società. Summa della sua opera
è Malina dove afferma la necessità della sofferenza
tramite le parole: “La lingua è castigo. Tutte le cose devono
entrare in essa e devono poi scomparire secondo la colpa e secondo la
misura della loro colpa.”
Nikola Harsch
*
Roma e Vienna, la doppia vita della Bachmann
“Ho visto che dicendo Roma si evoca ancora il mondo
e che la chiave della forza sono quattro lettere S.P.Q.R.” (Ingeborg
Bachmann, Quel che ho visto e udito a Roma). Ingeborg Bachmann,
poetessa e scrittrice austriaca, visse per molti anni a Roma dove morì
a causa di un terribile incidente il 17 ottobre 1973.
Nacque a Klagenfurt (Carinzia) nel 1926 e passò la sua infanzia
lì, vicino al confine con l’Italia. Nel 1945 lasciò
la casa dei genitori e dopo un anno di studi a Innsbruck e a Graz si trasferì
a Vienna dove rimase fino alla laurea in filosofia e dove cominciò
anche a scrivere poesie e radiodrammi. Nel 1952 fu invitata da Hans Werner
Richter, insieme a Paul Celan e Inge Aichinger, al decimo congresso del
Gruppo 47 che nel 1953 le assegnò un premio per la raccolta di
poesie Il tempo dilazionato. Nello stesso anno accettò
un invito a Ischia da parte del compositore Hans Werner Henze. Partì
per l’Italia lasciandosi alle spalle l’Austria dove non sarebbe
più ritornata tranne che per brevi visite. A Ischia scrisse le
poesie della raccolta L’Invocazione dell’Orsa Maggiore e furono in molti a dire che il suo stile si fosse trasformato positivamente
con il trasloco.
Nell’autunno del 1953 la Bachmann venne a Roma per la prima volta.
La decisione di trasferirsi nella capitale fu dettata dal bisogno di guadagnare:
per un anno scrisse come corrispondente per vari giornali tedeschi. La
sua idea fu quella di restare a Roma soltanto per qualche mese ma ci rimase
molto di più benché non poté mai spiegare il vero
motivo della sua decisione. Si stabilì nella capitale e presto
entrò a far parte della scena letteraria romana.
Collaborò alla rivista letteraria Botteghe Oscure e tradusse
le poesie di Giuseppe Ungaretti, si interessò di Morante e Manganelli,
scrisse un saggio sulla relazione tra la letteratura italiana e quella
tedesca e conobbe gli scrittori tedeschi che vivevano a Roma, tra cui
Marie Luise Kaschnitz e la figlia Iris, Hermann Kesten e quelli che frequentarono
come loro l’Istituto di Studi Germanici a Villa Sciarra. Spesso
le venne chiesto perché avesse scelto di vivere proprio a Roma.
Lei descrisse Roma come “una città aperta” con “un
carattere utopico” dove si riesce ad avere “una sensazione
di patria intellettuale”. In uno dei suoi pochissimi testi su Roma, Quel che ho visto e udito a Roma del 1954, descrisse proprio
questo.
Nel 1957 Ingeborg Bachmann lasciò Roma per alcuni anni. Si trasferì
a Monaco di Baviera dove accettò un posto in televisione come drammaturgo.
Conobbe lo scrittore svizzero Max Frisch con il quale fu legata in una
relazione molto movimentata fino al 1962. Con lui visse tra Roma e Zurigo,
ma fu soltanto dopo la fine del loro rapporto che nel 1966 decise di ritornare
definitivamente a Roma. Abitò in Via Bocca di Leone 60 (oggi una
lapide ricorda gli anni dal 1966 al 1971) e dopo si trasferì in
Via Giulia 66 dove visse fino alla morte. Soffrì di gravi problemi
di salute dovuti alla sua farmacodipendenza ma nonostante tutto lavorò
ininterrottamente al ciclo “Modi di morire”, una serie di
romanzi che dovevano avere come tema la morte dovuta alla società.
Summa della sua opera narrativa è Malina (1971), primo
romanzo del ciclo; il secondo romanzo del ciclo, Il caso Franza,
rimase incompiuto.
Quando la Bachmann parlò della sua vita a Roma alla fine degli
anni Sessanta, la chiamò Doppelleben, doppia vita. I suoi
racconti della raccolta Il trentesimo anno e anche i romanzi
furono, infatti, ambientati esclusivamente in Austria mentre lei viveva
nel cuore di Roma. “Sto meglio a Vienna perché sono a Roma;
senza questa distanza non potrei immaginarla per il mio lavoro.”
Ingeborg Bachmann non fu la tipica poetessa venuta dal Nord, piena di
ammirazione per l’Italia con la sua storia e i suoi monumenti, non
sentì il bisogno di descrivere continuamente la città eterna
come lo fecero molti dei suoi colleghi tedeschi. Sottolineò spesso
che per lei vivere in Italia fosse qualcosa di normale visto che era cresciuta
vicino al confine. Fu a Roma che trovò la libertà e la forza
per concentrarsi sul suo lavoro di scrittrice e dove seguì un impegno
ben preciso: “Il compito dello scrittore non può consistere
nel negare il dolore, nel nascondere le tracce, nel far nascere illusioni
su di esso. Per lui, anzi, il dolore deve essere vero e deve essere reso
tale una seconda volta, cosicché noi possiamo vederlo. Tutti, infatti,
vogliamo diventare vedenti. E solo quel dolore nascosto ci fa sensibili
all’esperienza e soprattutto all’esperienza della verità.
Quando siamo in questo stato in cui il dolore diventa fertile, stato che
è insieme chiaro e triste, noi diciamo, molto semplicemente, ma
a ragione: mi si sono aperti gli occhi. E non lo diciamo perché
abbiamo davvero percepito esteriormente un oggetto o un avvenimento, ma
proprio perché comprendiamo ciò che non possiamo vedere.
E l’arte dovrebbe portare a questo: far sì che, in tal senso,
ci si aprano gli occhi” (Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar).
Il dolore di cui la Bachmann parlò come via verso la percezione
di una realtà diversa è quello della guerra, il “dolore
troppo precoce” che aveva provato quando le truppe di Hitler invasero
Klagenfurt, l’amara scoperta della volontà di distruzione,
del desiderio di supremazia che si cela nelle relazioni umane, delle “ombre
cupe” che accompagnano la vita di tutti i giorni.
Nikola Harsch, l’Unità, 17 ottobre
2003
*
È buio fitto davanti alla finestra, non posso aprirla e premo il viso contro il vetro, non si riesce a vedere quasi niente. Lentamente ho l’impressione che il fosco specchio d’acqua potrebbe essere un lago e sento gli uomini ubriachi cantare sul ghiaccio un corale. So che dietro a me è entrato mio padre, ha giurato di uccidermi, e mi metto svelta tra la lunga tenda pesante e la finestra, in modo che non mi sorprenda a guardare fuori, ma so già quello che non debbo sapere: in riva al lago c’è il cimitero delle figlie uccise.
da Malina, Adelphi
*
Era proprio uno strano meccanismo il suo, viveva senza un solo pensiero in testa, immersa nelle frasi degli altri che immediatamente doveva ripetere come una sonnambula, ma con suoni diversi: di “machen” sapeva fare to make, faire, fare, hacer e delat’, era capace di girare ogni parola come su un rullo per ben sei volte, soltanto non doveva pensare che machen significava veramente machen, faire fare, fare fare, delat’ delat’, questo avrebbe reso la sua testa inservibile e lei doveva stare molto attenta a non venire un giorno travolta da quella valanga di parole.
da “Simultaneo”, Tre sentieri per il lago, Adelphi
*
il rogo è eretto sul Kurfürstendamm, angolo Joachimsthalerstraße. C’è il black-out dei giornali. Nessuno dei giornali con cui si può accendere il fuoco è uscito. L’edicola è vuota, non c’è neanche la giornalaia. La gente esita, poi ciascuno si fa coraggio e prende un ciocco. Alcuni si portano subito a casa il ciotto sotto il soprabito, altri cominciano lì sul posto a incidere nel legno col temperino quel che gli salta in mente: segni solari, segni di vita. Un aio di persone fanno osservazioni volgari e dicono che la legna è umida. Un uomo decrepito alza il suo ciocco e grida: sabotaggio! Li lasciamo cadere in mano agli altri! E davvero i ciocchi corrono già in cerchio, ognuno passa all’altro un ciocco, ma nessuno scherza col fuoco, tutti sono molto ragionevoli. Ben presto la legna è finita e il traffico riprende. Tutt’a un tratto i giornali escono, prima i giornali piccolissimi, con lettere in grassetto nero, con sottolineature cotennose, con grasso freddo in eccedenza che sgronda ai margini. Poi i giornali grandissimi, quelli magri, stracotti, ricoperti di brodo pallido, che si prendono in mano coi guanti.
da Luogo eventuale, Se
chiudi
|